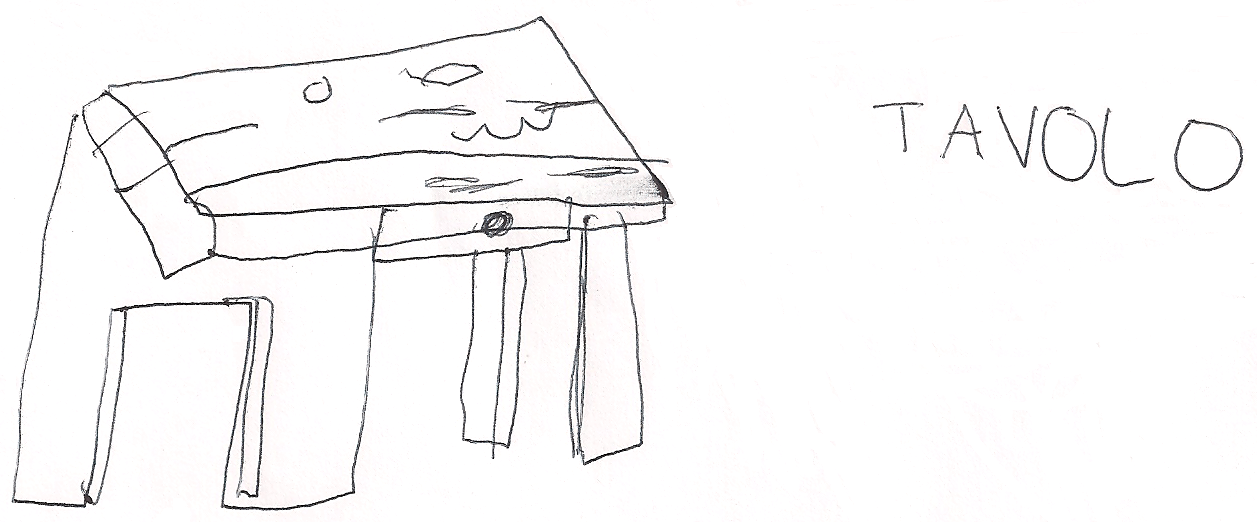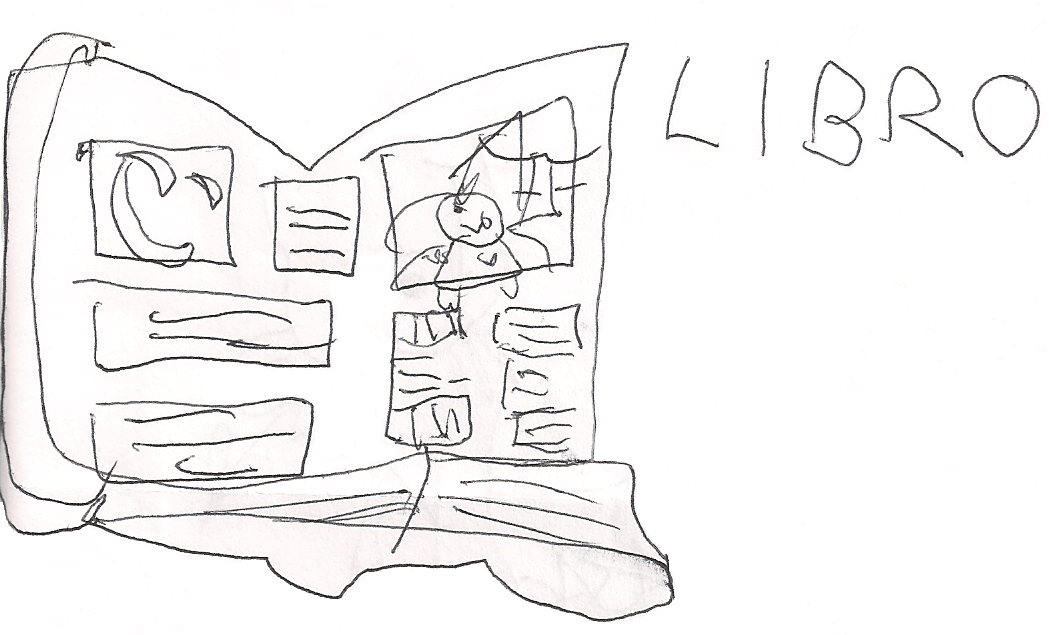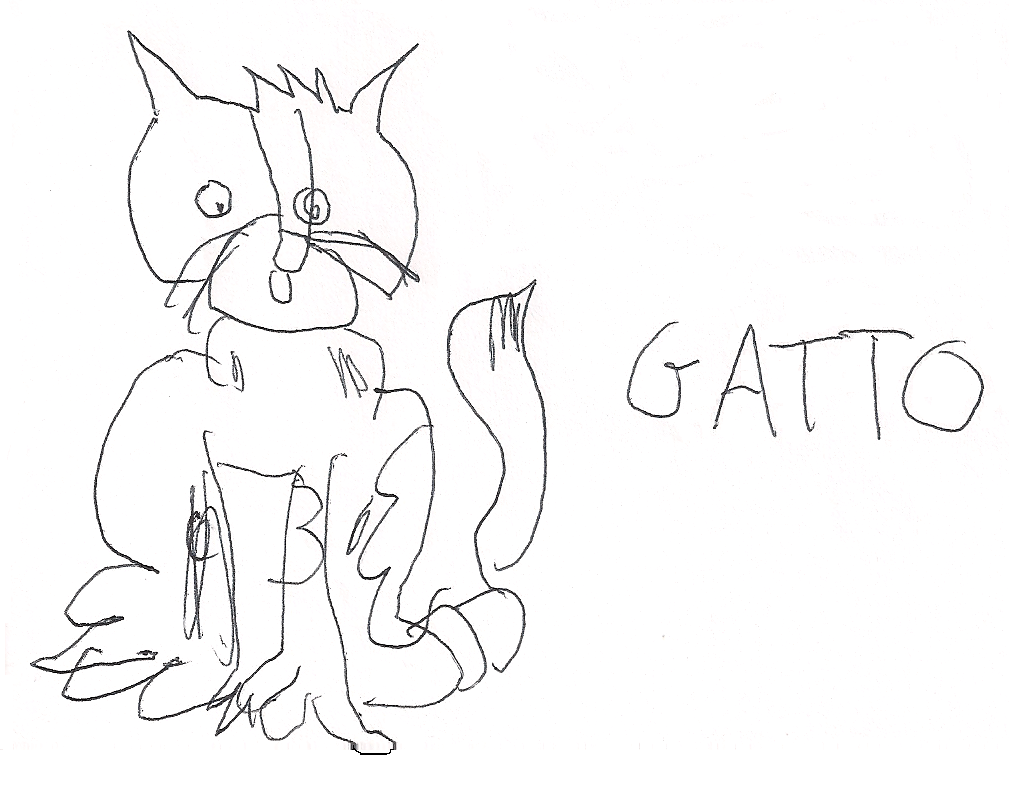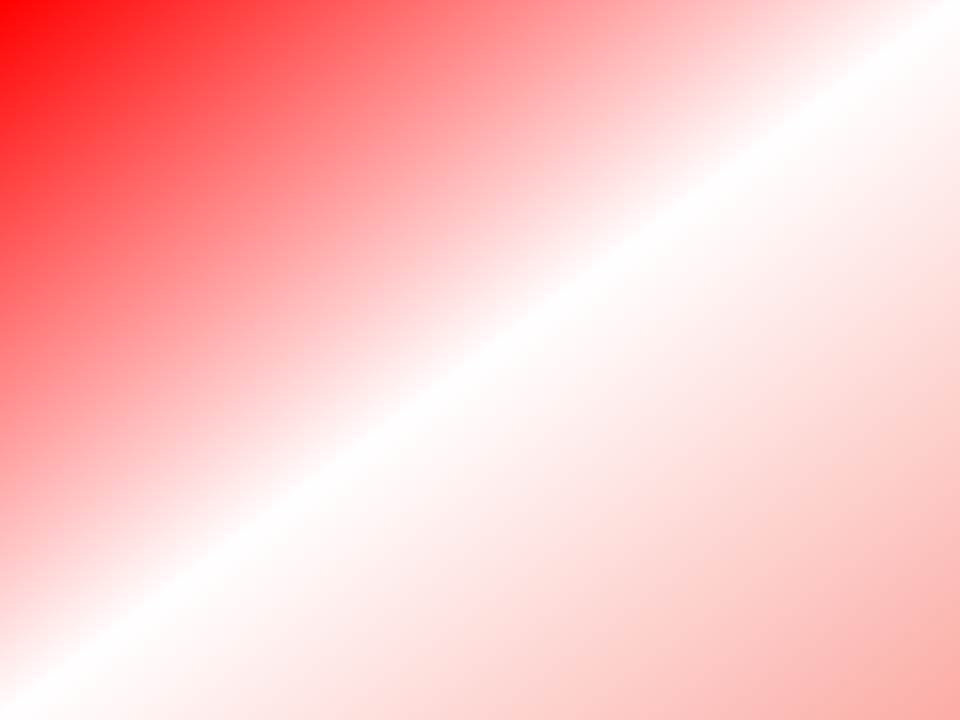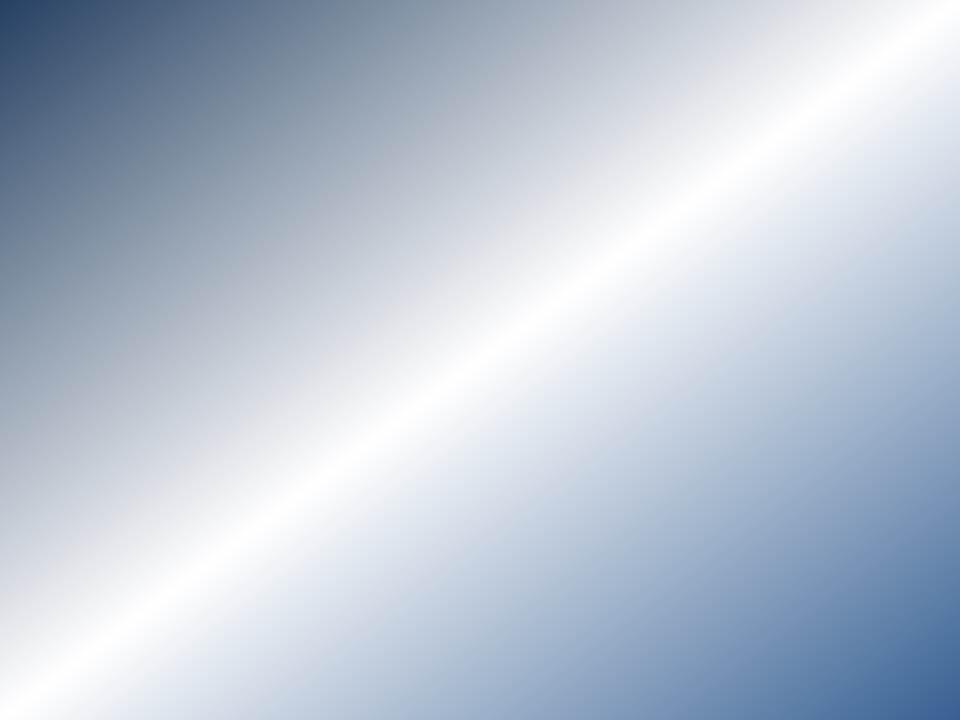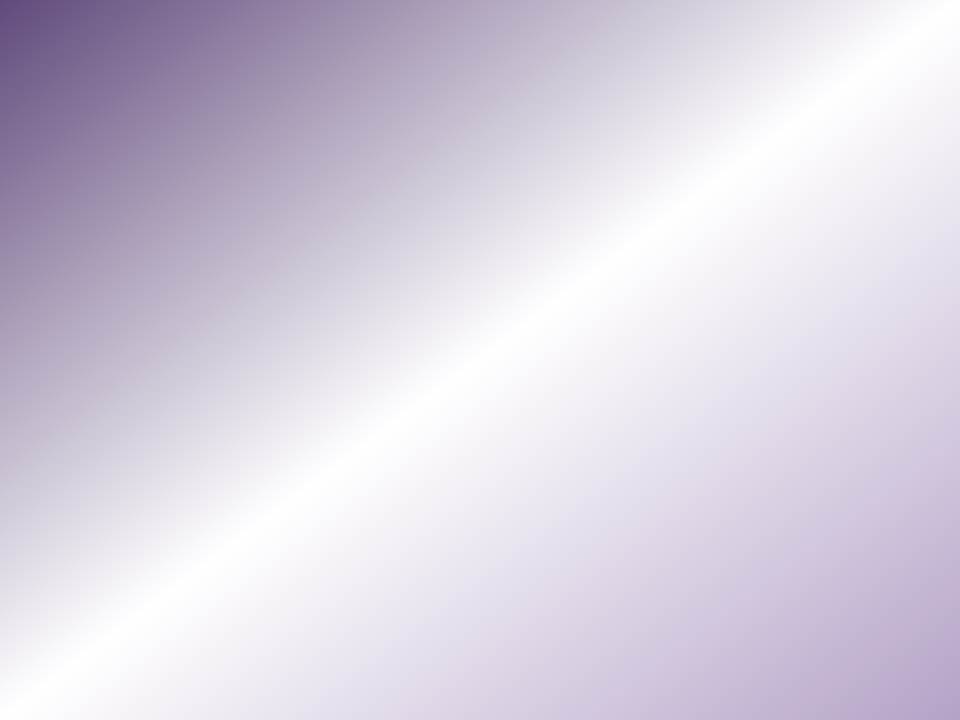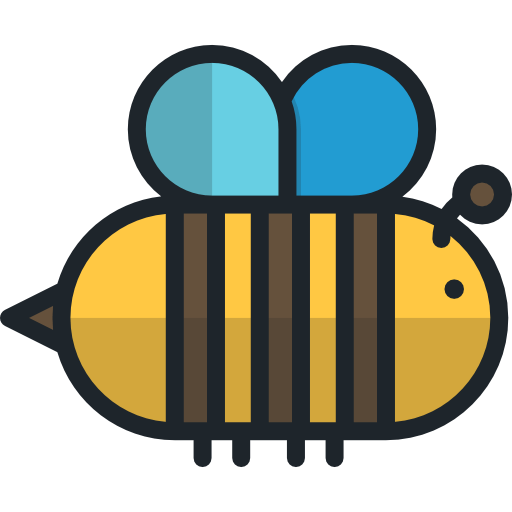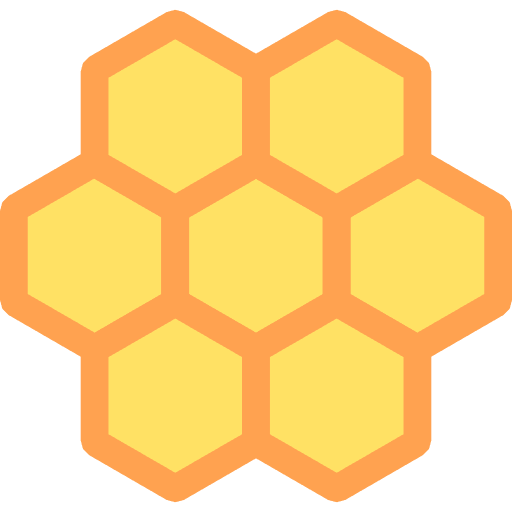I contenuti si ritrovano nel libro “Io mi svezzo da solo!” di Lucio Piermarini. I dipinti appartengono all’artista Alena Kalchanka. I sentimenti sono di ogni mamma. Alcune piccole attenzioni creano le condizioni migliori per il passaggio dal latte alle prime pappe. La mamma è serena e il bambino che cresce impara ad apprezzare sempre più il cibo. È possibile che tutto questo avvenga in modo gioioso e naturale.
Partenza senza riflessi
Normalmente, fino all’età di sei mesi circa, i bambini non sono in grado di assumere cibi diversi dal latte correttamente come noi pretenderemmo. La ragione sta nel fatto che i meccanismi di assunzione del latte, alimento liquido, con la suzione, sono, solo a pensarci un attimo ve ne renderete subito conto, del tutto diversi da quelli necessari per l’assunzione di cibi semisolidi o solidi con un cucchiaio.
Innanzitutto devono scomparire alcuni movimenti riflessi tipici dei bambini nei primi mesi di vita, cioè contrazioni e azioni involontarie, non controllate, di muscoli in seguito ad uno stimolo. Come quello che succede quando, con un martelletto, percuotiamo il tendine del ginocchio che sta subito sotto la rotula; la contrazione riflessa dei muscoli della coscia collegati a quel tendine solleva la gamba.
“Dopo non più, basta aspettare”
Il primo a doversene andare è quello che impedisce al bambino di aprire la bocca se si toccano le labbra. Quando si allatta, o è il bambino ad aprire spontaneamente la bocca, oppure si strofina il capezzolo sulla guancia e il bambino, anche questo è un riflesso, si gira verso il seno a bocca aperta.
Se si offre il seno forzando il capezzolo tra le labbra, il bambino tira fuori la lingua e lo sputa. Farà lo stesso con qualunque altro oggetto, cucchiaino compreso, fino al momento dovuto in cui il riflesso scompare. In passato, per superare questo ostacolo, si cercava di infilare profondamente nella bocca dei bambini il cucchiaino, ripulendolo poi sul labbro superiore e sul palato. Questa astuzia gabbava anche un altro riflesso, quello per cui se si stimola la metà posteriore della lingua, fino ad una certa età, si provoca il vomito, reazione utile a prevenire l’inalazione di corpi estranei. Niente di strano che più di un bambino, svezzato troppo presto, rischiasse di strozzarsi con le prime pappe, da cui la doverosa cautela. Dopo non più, basta aspettare.
 Poi il bambino si deve liberare della tendenza, sempre riflessa, a mordere ripetutamente, compulsivamente, tutto quello che si mette in bocca. Nel nostro caso farebbe ripetuti movimenti di semplice apertura e chiusura della bocca sul cucchiaino colmo di pappa, con l’ovvio risultato, come osservava Candida, il mandarne un po’ indietro, in gola, e un po’ avanti, fuori della bocca, costringendo la mamma a lavorare di cazzuola per evitare sprechi. Ma non basta. Durante la suzione la lingua, coordinandosi con la mandibola, si muove in senso antero-posteriore permettendo l’estrazione del latte dal seno che, durante la poppata, riempie completamente la bocca del bambino. Questo complesso meccanismo fa sì che il latte non si accumuli minimamente in bocca e, all’altezza della parte più posteriore della lingua, nella zona di congiunzione tra palato duro e molle, con l’avvio automatico del riflesso di deglutizione, passi direttamente nell’esofago.
Poi il bambino si deve liberare della tendenza, sempre riflessa, a mordere ripetutamente, compulsivamente, tutto quello che si mette in bocca. Nel nostro caso farebbe ripetuti movimenti di semplice apertura e chiusura della bocca sul cucchiaino colmo di pappa, con l’ovvio risultato, come osservava Candida, il mandarne un po’ indietro, in gola, e un po’ avanti, fuori della bocca, costringendo la mamma a lavorare di cazzuola per evitare sprechi. Ma non basta. Durante la suzione la lingua, coordinandosi con la mandibola, si muove in senso antero-posteriore permettendo l’estrazione del latte dal seno che, durante la poppata, riempie completamente la bocca del bambino. Questo complesso meccanismo fa sì che il latte non si accumuli minimamente in bocca e, all’altezza della parte più posteriore della lingua, nella zona di congiunzione tra palato duro e molle, con l’avvio automatico del riflesso di deglutizione, passi direttamente nell’esofago.
 Quando il cibo viene offerto con il cucchiaino, viene invece depositato nella parte anteriore della lingua o a metà, e da lì deve essere trasportato posteriormente fino al punto in cui si provoca la deglutizione. Trattandosi però di alimenti non più liquidi, questi devono essere bene impastati con la saliva e masticati al meglio, prima con le aguzze gengive e poi con i molari per poter arrivare senza rischi e in condizioni idonee alla digestione, fino all’esofago. Il movimento riflesso antero-posteriore della lingua sarebbe d’impaccio ed è solo con la comparsa di tutta la complicata serie di movimenti, stavolta volontari, in senso laterale, di lingua, guance e mandibola che il processo si perfeziona fino a completarsi verso i dodici mesi. Anche questa abilità compare a tempo debito, e non è cosa da poco. Provate a fare un’attenta osservazione su voi stesse e scoprirete quanto elaborato sia tutto il processo e quanto preciso esso debba essere per evitare sia di mordere la lingua invece del cibo, sia di indirizzare il cibo, una volta arrivato sulla rampa di lancio, verso un erroneo bersaglio, cioè in trachea invece che in esofago.
Quando il cibo viene offerto con il cucchiaino, viene invece depositato nella parte anteriore della lingua o a metà, e da lì deve essere trasportato posteriormente fino al punto in cui si provoca la deglutizione. Trattandosi però di alimenti non più liquidi, questi devono essere bene impastati con la saliva e masticati al meglio, prima con le aguzze gengive e poi con i molari per poter arrivare senza rischi e in condizioni idonee alla digestione, fino all’esofago. Il movimento riflesso antero-posteriore della lingua sarebbe d’impaccio ed è solo con la comparsa di tutta la complicata serie di movimenti, stavolta volontari, in senso laterale, di lingua, guance e mandibola che il processo si perfeziona fino a completarsi verso i dodici mesi. Anche questa abilità compare a tempo debito, e non è cosa da poco. Provate a fare un’attenta osservazione su voi stesse e scoprirete quanto elaborato sia tutto il processo e quanto preciso esso debba essere per evitare sia di mordere la lingua invece del cibo, sia di indirizzare il cibo, una volta arrivato sulla rampa di lancio, verso un erroneo bersaglio, cioè in trachea invece che in esofago.
La variabilità biologica
Sarà un caso, ma tutta questa serie di competenze motorie del bambino comincia a comparire dopo i quattro mesi e si completa e perfeziona proprio a circa sei mesi. Il “circa” è d’obbligo, per l’epoca di svezzamento come per tutto ciò che riguarda in generale il nostro organismo.
 Il motivo è semplicemente che tutti gli esseri viventi, e gli esseri umani non fanno eccezione, pur obbedendo alle stesse specifiche leggi biologiche, presentano per ogni loro carattere, quelle differenze che fanno di ciascuno un individuo unico e irripetibile. Così per lo svezzamento, il tempo di maturazione delle abilità necessarie, di cui abbiamo descritto per ora solo quelle motorie, non è identico per tutti i bambini, pur situandosi intorno a una certa età prevedibile che sono appunto i sei mesi di vita. E’ abbastanza comune perciò trovare bambini che si mostrano maturi anche una o due settimane prima o dopo i sei mesi. Più raramente si va oltre questi limiti, anche se, casi di ritardo fino a setto otto mesi non sono eccezionali. E’ possibile, prendetela però per una speculazione, che questi bambini non abbiano un reale bisogno di integrare la loro alimentazione lattea prima di quella data, e quindi, ancora una volta, fidarsi del bambino risulterebbe la scelta migliore.
Il motivo è semplicemente che tutti gli esseri viventi, e gli esseri umani non fanno eccezione, pur obbedendo alle stesse specifiche leggi biologiche, presentano per ogni loro carattere, quelle differenze che fanno di ciascuno un individuo unico e irripetibile. Così per lo svezzamento, il tempo di maturazione delle abilità necessarie, di cui abbiamo descritto per ora solo quelle motorie, non è identico per tutti i bambini, pur situandosi intorno a una certa età prevedibile che sono appunto i sei mesi di vita. E’ abbastanza comune perciò trovare bambini che si mostrano maturi anche una o due settimane prima o dopo i sei mesi. Più raramente si va oltre questi limiti, anche se, casi di ritardo fino a setto otto mesi non sono eccezionali. E’ possibile, prendetela però per una speculazione, che questi bambini non abbiano un reale bisogno di integrare la loro alimentazione lattea prima di quella data, e quindi, ancora una volta, fidarsi del bambino risulterebbe la scelta migliore.
“Se non si rispettano i tempi fisiologici”
[…] Volendo ad ogni costo forzare i tempi, le difficoltà che si incontrano nell’avviare e mantenere la somministrazione di cibi solidi in questi specifici casi, sono tali e tante da favorire nei bambini la comparsa di vere e proprie patologie del comportamento alimentare e, nella famiglia nel suo insieme, seri disturbi relazionali. In parole povere, tutti diventano antipatici a tutti. […]
“Lo svezzamento del bambino prematuro”
Un caso specifico è quello dei bambini nati prematuri in cui la velocità dello sviluppo neurologico è solo modestamente influenzata dall’esperienza.
 Se un bambino è nato prematuro di due mesi, questo anticipo, all’età anagrafica di sei mesi ci sarà ancora tutto, per cui il suo comportamento sarà come quello di un bambino di quattro. Non c’è nessun problema ad aspettare che anche lui mostri spontaneamente di essere pronto.
Se un bambino è nato prematuro di due mesi, questo anticipo, all’età anagrafica di sei mesi ci sarà ancora tutto, per cui il suo comportamento sarà come quello di un bambino di quattro. Non c’è nessun problema ad aspettare che anche lui mostri spontaneamente di essere pronto.
Le eventuali carenze nutrizionali legate alla sua nascita anticipata potranno essere corrette, come correttamente si fa, con opportuni integratori , senza mettere a rischio la sua salute forzando la mano.
“Tutto secondo natura”
Insomma, tutto si svolge come se qualcuno avesse disposto le cose in modo che, quando compaia il bisogno di integrazione del latte materno, il bambino sia maturo per assumere agevolmente e senza rischi alimenti diversi dal latte. Miracolosamente quello che prima per il bambino era di una difficoltà insormontabile, è ora facile e senza rischi. Il cucchiaino, l’odiato violentatore di uno o due mesi prima, ora scivola in bocca senza ostacoli e senza traumi. Esce perfettamente pulito, e pulito, o quasi, è il bambino.
“Svezzamento improprio”
Tutta l’inutilità del cosiddetto allenamento precoce al cucchiaino con la frutta, per facilitare il gran passo successivo, è ormai chiara. Inoltre, anche l’introduzione della sola frutta non è affatto innocua, in quanto assimilabile ad uno svezzamento improprio, perché, sostituendosi comunque ad una parte di latte, sottrae una quota di nutrimento di qualità più elevata.
“La sensibilità della mamma”
 Siamo sicuri che Candida, ormai sulla traccia delle fonti sicure di informazione, prima o poi verrà a conoscenza di quanto abbiamo detto e si rassicurerà. Anche se, quando fosse riuscita a sottrarsi alle nefaste influenze extra-familiari, siamo certi che la sua sensibilità di mamma l’avrebbe comunque messa in condizione di riconoscere le abilità di suo figlio.
Siamo sicuri che Candida, ormai sulla traccia delle fonti sicure di informazione, prima o poi verrà a conoscenza di quanto abbiamo detto e si rassicurerà. Anche se, quando fosse riuscita a sottrarsi alle nefaste influenze extra-familiari, siamo certi che la sua sensibilità di mamma l’avrebbe comunque messa in condizione di riconoscere le abilità di suo figlio.
Per ora è sufficientemente serena riguardo al fatto che aspettare non comporterà rischi nutrizionali per il bambino e guarda fiduciosa alla fatidica scadenza, sperando che il rispetto dei tempi fisiologici basti ad evitare i problemi che ha incontrato al primo tentativo.
Vedremo.
Tratto da “Io mi svezzo da solo! – Dialoghi sullo svezzamento” di Lucio Piermarini (Bonomi Editore sas, 2008)
Perchè la mia bimba ha 9 mesi e ama mangiare e questo libro è ancora sul mio comodino…
La magia dei colori è per gentile concessione dell’artista Alena Kalchanka
L'articolo “Io mi svezzo da solo!” di Lucio Piermarini sembra essere il primo su Logopedia Eulalia - Studio della Logopedista Elena Ferino di Padova.